Poeta o narratore? Crepuscolare o futurista? È pressoché impossibile imbrigliare il genio creativo di Aldo Palazzeschi (Giurlani all’anagrafe, ma la sua giovanile passione per il teatro non era molto gradita a suo padre, così prese il nome della nonna materna senza cambiarlo neppure quando abbandonò la carriera di attore per quella di letterato), universalmente riconosciuto come una delle figure di maggiore spicco della letteratura italiana contemporanea.
La poesia di Aldo Palazzeschi
Curiosi e al tempo stesso coraggiosi i suoi esordi, affidati alle stampe dell’immaginario editore fiorentino Cesare Blanc, di cui aveva inventato anche indirizzo e recapiti (ma non il nome: era quello del suo gatto!). Na non ci volle molto perché il mondo culturale di allora si accorgesse delle sue capacità e lo pubblicasse un editore vero, con tanto di rotative e correttori di bozze.
Nei primi esercizi poetici contenuti in I cavalli bianchi e Lanterna, nonostante la giovane età dell’autore, ricorrono i temi della vecchiaia, della morte, della malattia. Il metro utilizzato è il trisillabo e lo stile molto vicino a quello dei poeti crepuscolari, smorzato e malinconico.
I Poemi e il futurismo
Un altro ad accorgersi ben presto del suo estro del tutto singolare – forse anche perché, come dice il proverbio, “chi si somiglia si piglia” – fu il patriarca futurista Filippo Tommaso Marinetti. Egli, dopo aver letto la sua terza raccolta, Poemi, gli scrisse, entusiasta dell’uso che faceva del verso libero, caratteristica che indiscutibilmente lo avrebbe legato al movimento futurista. Palazzeschi accettò di buon grado, collaborando a riviste futuriste e dedicando addirittura la successiva raccolta di poesie, L’incendiario, proprio a Marinetti, definendolo “l’anima della nostra fiamma”.
Ma il matrimonio tra Palazzeschi e il Futurismo non era di quelli destinati a durare per sempre. Il vigore e la vitalità del gruppo, troppo spesso sfociante in deliberata aggressività, non collimavano con la personalità assai più pacata del poeta fiorentino. La rottura arrivò nel 1914, e su un tema molto importante: se l’Italia dovesse intervenire o meno nella Grande Guerra. Sappiamo come andò a finire.
Tri, tri tri
Fru fru fru,
uhi uhi uhi,
ihu ihu, ihu.Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente.Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto…
Il romanzo di Aldo Palazzeschi
Da questo momento e fino all’ultimo dei suoi 89 anni, Palazzeschi restò sempre in bilico tra prosa e poesia, sfornando capolavori e collezionando successi in entrambi i campi letterari.
Il codice di Perelà
Il romanzo che lo consacrò narratore risale al 1911 ed è Il codice di Perelà, scritto in pieno periodo futurista, del cui movimento si ravvisano i consueti temi, mentre lo stile – straordinario – è più che mai innovativo, a metà tra il romanzo destrutturato e il testo teatrale. Il protagonista, infatti, un omino di fumo (titolo con cui in seguito verrà ripubblicata l’opera) che viaggia verso la città al grido “PEna! REte! LAma!” (l’acronimo Perelà, appunto), passa attraverso gli eventi senza farsene toccare, parla pochissimo con i personaggi che incontra sul suo cammino, e quando lo fa è solo per raccontare la sua storia di omino di fumo “leggero leggero”.
Antiromanzo, favola allegorica, ancora una volta sfuggono le definizioni per questo lavoro geniale di Palazzeschi, che in seguito, nella sua produzione narrativa, sarà capace anche di rientrare nei canoni del romanzo tradizionale.
Sorelle Materassi
È il caso delle Sorelle Materassi, pubblicato con Vallecchi nel 1934. Questa la trama. In una provincia di Firenze tranquilla e sonnolenta, vivono tre ricche sorelle – qualcuna zitella, qualcuna ripudiata – che per lavoro cuciono meravigliosi abiti da sposa. La loro vita viene sconvolta, però, dal nipote belloccio e nullafacente, figlio della quarta sorella defunta, Remo, che con le sue armi da seduttore di vecchie signore, mezzo Casanova di provincia, le fa finire sul lastrico per soddisfare ogni suo capriccio.
Roma
Del Palazzeschi anziano, invece, è Roma, uscito nel 1953. In questo romanzo, scritto dopo il riavvicinamento del poeta alla religione cattolica, protagoniste sono proprio la città e la Chiesa. Sono totalmente scomparsi il tono dissacrante degli anni futuristi, ma anche il sottile humor quasi vignettistico di molte delle sue opere.
Aldo Palazzeschi, un battitore libero
Troppo scherzoso e divertito il suo tono per essere un crepuscolare, ma anche troppo serioso e in definitiva intimo il suo stile per i futuristi, Palazzeschi era un battitore libero ma anche un poeta e un uomo del suo tempo (e che tempo!), che si avvicinava con sana curiosità ad ogni avanguardia artistica. Per lui, alla fine, i critici del Novecento sono riusciti a coniare una definizione che è forse quella più bella e più azzeccata per la sua opera, che fu un’immensa, multiforme, sfaccettata “favola surreale e allegorica”.
D’altronde lui stesso, in uno dei rari momenti in cui cercò di autoetichettarsi, disse di sé semplicemente di avere la vocazione al gioco, alla fantasia e al riso, in tutte le sue forme e le sue declinazioni: dalla risata rumorosa al sorriso sotto ai baffi; dalle risa sguaiate ai timidi sorrisi cercati sui volti degli affetti più cari; dalle prese in giro più canzonatorie alle risate beffarde di chi la sa lunga.
Tri, tri tri
Fru fru fru,
uhi uhi uhi,
ihu ihu, ihu.Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente.Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto…
Foto | Mario Nunes Vais (1856-1932). [Public domain], via Wikimedia Commons


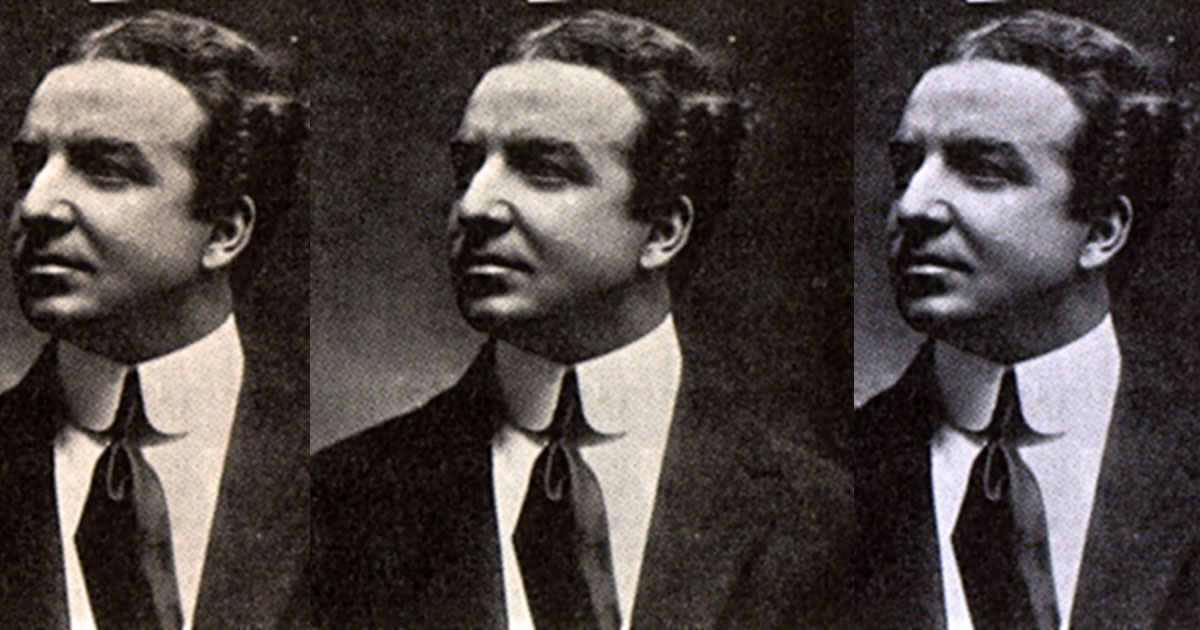




Lascia un commento